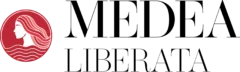Il rugby è respiro. È cuore e anima, porta con sé lo spirito di squadra attraverso l’obiettivo comune della vittoria, ma allo stesso tempo è individualità verso la consapevolezza di poter vincere anche per se stesse. Vincere sfide che vanno oltre il campo da gioco.
Erika Morri non ha mai smesso di respirare rugby. Di respirare sport. Lo sport è diritti, è valore, è emancipazione ed empowerment. Rugbista d’eccellenza, ha indossato la maglia azzurra dal 1990 al 2012 partecipando a due Coppe del Mondo e sette Europei. Ma non solo. Morri è la fondatrice del progetto Wo*men’s sport land of freedom: chi semina sport raccoglie futuro. E, oltre a essere formatrice e speaker, oggi ricopre il ruolo di Consigliera della Federazione Italiana Rugby, è membro del Committee per lo sviluppo del rugby femminile di Rugby Europe, e rappresenta l’Italia nella Federazione mondiale World Rugby.
Inoltre, il suo libro Empowerment per la vita. La meta del rugby femminile (Armando ed.), scritto in collaborazione con Simona Castellano e il team della Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, rappresenta un intenso viaggio nel mondo del rugby come strumento educativo e di emancipazione. Al suo interno, infatti, vi è uno studio tra i più importanti a livello mondiale, sulla capacità che lo sport da di incidere sul nostro quotidiano, l’ agency. Lo studio è stato compiuto sulla storia di 135 rugbiste di 60 culture differenti… storie di donne che, attraverso il rugby, sono riuscite a superare sfide economiche, familiari e sociali. Atlete che hanno trovato, nel rugby, un’opportunità per ridefinire la propria identità e crescere, trasformarsi e riscattarsi.
Il rugby può favorire l’emancipazione femminile?
Il rugby è uno sport di contatto, e questo lo rende potentissimo dal punto di vista culturale. In molte società, alle bambine non si permette di usare i piedi per giocare, di avere un contatto fisico sfidante, di sporcarsi: sono attività considerate “da maschi”. Nel rugby, una ragazza scopre che il corpo è suo, che ha forza, che può affrontare un contrasto, perfino placcare una persona lanciandosi sulle gambe per fermarla: un gesto totalmente tecnico e regolamentato, ma pieno di significato. È un’esplosione di autodeterminazione e che fa riflettere sulla propria condizione: se ho avuto il coraggio di fare questo, posso affrontare molto altro nella vita.
Tu stessa, da ex Azzurra, hai raccontato di aver ignorato gli stereotipi dei suoi tempi. Che cosa significava per te giocare a rugby come donna?
Sono una donna minuta, 1,61 per 52 kg, e nessuno direbbe che sono una rugbista. E questo rompe già uno stereotipo. Quando ho iniziato c’era una forte “mascolinizzazione” estetica: si pensava che, chi giocasse a rugby, fosse per forza “poco femminile”, con un corpo fuori norma. Io, invece, mi sono sempre presentata per come sono: : a volte in jeans, a volte andavo agli allenamenti col tacco 12. Essere curate o eleganti deve essere una scelta personale, non un modo per essere accettate. E la cosa più importante è giocare perché lo ami, non per dimostrare qualcosa agli altri.
Hai incontrato storie di donne che ti hanno colpito particolarmente?
Tantissime. La prima risale agli albori del nostro sport, quella di Emily Valentine (1878-1967), considerata la prima giocatrice al mondo: si travestiva da bambino per poter giocare e ha lasciato un diario che racconta il suo desiderio di libertà. Abbiamo lavorato sulla sua storia con un progetto artistico internazionale di Latitudo Art Project, che si è concluso al MAXXI di Roma, coinvolgendo droni, musica, performance. È stato emozionante.
Poi salto quantico ai nostri giorni, la storia di Ilona Maher, la giocatrice americana con 5mln di follower: è alta, imponente, muscolosa. Nel rugby trova spazio e ruolo, e tantissime ragazze si riconoscono in lei. La Mattel ha creato una Barbie a sua immagine CON I BICIPITI! Ovvero un cambio culturale importantissimo che varia lo stereotipo di bellezza dando spazio a tutte le fisicità. In una società dove una donna grande rischia di essere insultata, nel rugby trova serenità, utilità e dignità. Lo sport può cambiare la percezione del proprio corpo.
Ci sono ancora pregiudizi sul rugby femminile? Cosa rispondi a chi dice che è “un altro sport”?
Molti pensano che le donne, giocando in modo diverso, facciano “un altro sport”. Io rispondo sempre che l’uguaglianza non significa essere uguali agli uomini, ma avere gli stessi diritti di espressione. Quando guardi una partita femminile non stai vedendo qualcos’altro: stai vedendo rugby giocato con caratteristiche diverse. È spesso più dinamico, più creativo, più “spumeggiante”, proprio perché non abbiamo la stessa potenza fisica degli uomini e sviluppiamo altre qualità che si vedono in un gioco meno di “sportellate” o calci lunghi, ma che si sviluppa ricercando gli spazi.
Anzi, molte persone trovano le nostre partite più divertenti. Quindi quando qualcuno dice “il vostro è un altro rugby”, io rispondo: «Perfetto. Vieni a vederci».
Nel 1991 è stato organizzato, da quattro donne rugbiste tra cui Deborah Griffin, che è una delle tue intervistate (nel 2025, è stata eletta presidente della Rugby Footbal Union (RFU), ovvero la Federazione inglese), il primo Mondiale femminile di rugby. Prima d’allora, le donne non avevano un proprio mondiale, né competizioni internazionali, non erano riconosciute ufficialmente dal sistema. Tu hai partecipato proprio a quel primo Mondiale. Cosa ha rappresentato?
È stato storico. Era il primo Mondiale femminile della storia, organizzato da quattro giocatrici senza sponsor, senza supporto ufficiale, senza riconoscimenti. Solo passione e coraggio. Per me, è stato importante proprio a livello storico.
In Italia, all’1 dicembre 2025, la Nazionale è al decimo posto nel ranking mondiale. Eppure, non sono considerate professioniste dalla legislazione italiana. Cosa manca oggi per il raggiungimento del professionismo femminile?
La risposta è semplice: i soldi. Senza sponsor non fai comunicazione per il reclutamento, senza reclutamento non allarghi la base, senza basa larga non ottieni risultati. Eppure l’Italia è un miracolo, con 4.000 giocatrici totali contro le 45.000 in Francia e quasi le 50.000 in Inghilterra, essere state seste al mondo sino a qualche mese fa è impressionante. Le nostre atlete studiano, lavorano, non sono professioniste. È un risultato enorme. La federazione oggi sta facendo passi in avanti, ma abbiamo ancora molta strada
Che cosa insegna davvero il rugby nella vita quotidiana?
Il rugby è un’enorme palestra di educazione emotiva. Ti insegna a sostenere chi sbaglia, a gestire la frustrazione, a parlare nei momenti difficili, a riconoscere le tue emozioni quando sei sotto stress. È un gioco in cui non esistono “panchinari”: chi entra è “energia nuova”, e spesso è proprio quell’energia che fa vincere una partita. Nel rugby non ci sono stelle: ci sono costellazioni. È un gioco di gruppo, dove si va avanti insieme. Proprio come dice quel proverbio africano che amo: “Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme”.
Cosa vuol dire crescere con il rugby? Giocare insieme aiuta davvero l’equità?
Assolutamente sì. Nel rugby maschi e femmine giocano insieme fino ai 12 anni. Questo, per me, significa seminare equità dal campo, senza slogan. Bambini e bambine condividono tutto: fango, cadute, vittorie, sconfitte, fatica, frustrazioni. E spesso, fino a quell’età, le bambine sono più forti dei bambini. Non è la bimba “fragile” che gioca con i maschi: molte segnano metà delle mete della squadra. Questo crea un confronto reale, non teorico. Lo spogliatoio è una piccola società: il timido, la simpatica quello tecnico che non parla, quella che sbaglia sempre ma fa armonia… lì impari a gestire emozioni, malumori, conflitti. È lì che nasce il potere educativo dello sport.
Da qui anche il bellissimo progetto “Wo*men’s sport land of freedom: chi semina sport raccoglie futuro”. Cosa rappresenta?
La parola Women è scritta WO*MEN che se si legge senza asterisco significa donne. Ma con l’aggiunta dell’asterisco Wo*MEN, MEN ricorda che il progetto riguarda anche gli uomini, l’asterisco rappresenta tutte le persone che non si identificano in nessuna delle due categorie.
Per noi, Wo*men’s Land of Freedom” lavora e si fonda su quattro pilastri che sono riconosciuti anche tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU: Parità di genere, Istruzione di qualità, Salute e benessere, Pace. Lo sport è un laboratorio di vita: ti mette alla prova ma in un ambiente protetto, dove puoi sperimentare chi sei.
E, al suo interno, il progetto L’Ottavo Continente in cui sono state raccolte le storie di oltre 135 donne provenienti da 60 paesi diversi, dall’Uganda all’Argentina, dall’Iran alla Nuova Zelanda. Le abbiamo interrogate su come il rugby abbia trasformato le loro vite e soprattutto come il rugby sia nato nei loro Paesi, scoprendo che, al di là delle differenze culturali, i temi ricorrenti sono simili: autodeterminazione, sorellanza, la forza di ignorare il giudizio e la capacità di gestire le emozioni. Queste testimonianze confermano che il rugby è un potente strumento di empowerment.
Da “L’Ottavo Continente” nasce quindi il libro, “Empowerment per la vita. La meta del rugby femminile”, inserito nella collana “I futuri della didattica” di Scienze dell’educazione dell’Università di Bologna, edito da Armando editore, che parla di donne come l’argentina Gisela Acuña, la quale ha dichiarato come ancora oggi sia “innamorata del rugby, perché tutte quelle ferite, che oggi porto nel cuore e sulla pelle, mi ricordano la persona che ero, quella che è maturata e cresciuta come una persona che oggi è orgogliosa, nonostante le lacrime di tristezza o di gioia, di essere disciplinata, rispettosa, onesta, laboriosa e appassionata. Grazie al rugby per avermi trovata, e grazie alla vita per avermi fatto trovare il rugby”. E le tante altre testimonianze che, proprio come Morri, rendono il rugby uno sport che lascia respirare, sognare e soprattutto vivere.
Caterina Caparello