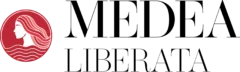Un percorso sulle donne vincitrici del Premio Pulitzer in 5 tappe: 1921-1942; 1961-1988; 1989-2000; 2009-2024
Nel 1905 tutta la città di New York fu sconvolta e affascinata dalla storia di Lily Bart, una giovane donna che, facendo affidamento sulla propria bellezza e sul proprio ingegno, spera di trovare il proprio posto nell’alta società newyorkese sposando un uomo ricco. Ha già 29 anni, dunque, secondo le aspettative della società di quegli anni, straordinariamente in ritardo per il matrimonio. Coinvolta in una serie di spiacevoli vicissitudini, per Lily Bart trovare marito risulta sempre più difficile, le sue prospettive di matrimonio si disgregano e la sua vita comincia a precipitare in un abisso. Caduta in povertà, prende una stanza in affitto, dove, in overdose di sonniferi, muore.
Questa tragica figura, roteante nel baratro della condanna sociale, non è reale. È la protagonista del romanzo La casa della gioia di Edith Wharton (1862-1937) ed ebbe una grande risonanza nella società aristocratica americana del primo ‘900. Tutti i romanzi di Wharton indagano dinamiche matrimoniali infelici, attraverso le quali l’autrice denuncia il lato oscuro di una classe sociale di cui lei stessa è parte. Il mezzo della denuncia era, appunto, la scrittura, attività che svolgeva di nascosto, la mattina presto, quando era ancora a letto.
Il suo nome da nubile fu Edith Jones e, fin da bambina, leggeva per evocare mondi alternativi che fossero ben più interessanti e fantasmagorici di quello in cui si ritrovava a vivere. Nata nel 1862, negli anni ’70 dell’Ottocento si sentiva profondamente fuori posto, velata di una timidezza che veniva spesso scambiata per arroganza. I suoi genitori erano preoccupati che, a causa dei suoi interessi “stravaganti” (ovvero l’amore per la letteratura), avrebbe fatto fatica a trovare marito, così cercarono di combinarle un matrimonio quando era ancora giovanissima, prima che diventasse tanto colta da spaventare tutti i possibili pretendenti. In un certo senso avevano ragione: il suo primo fidanzamento durò poche settimane: il signor Stevens, aveva notato in Wharton una eccessiva preponderanza di intellettualità, considerandola troppo ambiziosa per i suoi gusti. Conobbe un secondo uomo, Edward Wharton, che sposò dopo appena un mese di fidanzamento sebbene la sola cosa che avevano in comune fosse l’amore per i cani. Wharton adempiva tutte le sue mansioni di moglie, dedicandosi, seppur controvoglia, agli impegni che la vita mondana richiedeva.
Ma non smise di scrivere: scrisse almeno un libro l’anno, con un unico tema centrale. Il matrimonio infelice. Proprio come lo era il suo. Gli eventi della sua vita cominciarono a diventare materia di scrittura: il senso di asfissia, l’assenza di libertà, la totale infelicità derivati dal proprio matrimonio con Wharton la spinsero, quando aveva 45 anni, a cercare conforto in una relazione extraconiugale con Morton Fullerton, personaggio tanto attraente quanto inaffidabile. La relazione si concluse dopo tre anni di costante oscillare tra passione e disperazione. Il tema del “terzo” che irrompe nel rapporto coniugale per portare dapprima l’illusione della salvezza e poi la devastazione, attraversa, infatti, i due romanzi più famosi di Wharton. Ethan Frome, che diventerà immediatamente un successo, e L’età dell’innocenza che le varrà il Pulitzer nel 1921. Un affresco estremamente lucido della società newyorkese del primo Novecento in cui l’esistenza si regge su una rigida impalcatura di consuetudini e ruoli prestabiliti che uomini e donne, come attori che recitano una parte, rispettano irreprensibilmente. Da questo contesto si innalza l’eroe della storia, Newland Archer, sospinto ad abbandonare quella danza di maschere che lo vogliono integro nelle sue convinzioni per spaccarsi a metà tra il fidanzamento con May, socialmente perfetta, e l’attrazione per la cugina di lei, Ellen, che vive a Parigi, incastrata a sua volta in un matrimonio infelice.
Ancora una volta, una figura esterna mette in crisi la validità del matrimonio. Eppure, se in Ethan Frome la storia approderà alla conclusione di un macabro trio, in questo romanzo, Ellen romperà l’incantesimo mostrando ad Archer la cruda realtà: non è nella fuga che si può sperare di trovare salvezza. Non c’è posto nel mondo in cui la mentalità sia diversa da quella del luogo in cui essi vivono e nel quale non possono trovare pace. Non sarebbero mai stati liberi di amarsi. L’età dell’innocenza è romanzo della passione ma anche, e soprattutto, del rimpianto. Delle domande che Archer, molti anni dopo, si farà seduto su una panchina a Parigi, a spiare la luce di una finestra dentro la quale avrebbero potuto esserci lui ed Ellen. Felici. Ma proprio in quel momento la domestica chiude le persiane, serrando una volta per tutte il solo squarcio sulla sua vita possibile.
Edith Wharton, nel 1921, è la prima donna a vincere il Premio Pulitzer per la narrativa.

Con Uno dei nostri, nel 1923, è Willa Cather (1873-1947) la seconda donna a vincere il Premio Pulitzer. Gli occhi chiari, il viso sereno, nelle foto ufficiali quasi sempre ritratta con una camicia bianca, alle volte con una cravatta un po’ slargata attorno al collo. Voleva essere come Virgilio, voleva essere come Dickens. Scrisse il suo primo romanzo a 40 anni, ritenendolo, poi, un fallimento. Divenne realmente la scrittrice che voleva essere quando raccolse tutto il proprio coraggio per guardarsi dentro e affrontare quella che era stata la sua paura più grande. Una prateria immensa, un verde sconfinato, una distesa che non aveva fine. E lei su un carro che viaggiava veloce e avrebbe viaggiato per giorni. E mai un albero, mai una casa, mai un fiume. Nemmeno un orizzonte. Era solo una bambina quando si trasferì con la famiglia dalla Virginia al Nebraska. Quel cambiamento le strappò via la pelle. Si sentiva senza forma, senza identità. Arrivati in Nebraska, Cather bambina pianse un anno intero.
Ma è in quel ricordo che Cather trova la sua vera voce. Sarebbe stata la scrittrice delle praterie: di O Pioneers!, The song of the lark e My Antonia (conosciuti come la “Trilogia della prateria”). La scrittrice che dà voce agli immigrati, svedesi, cechi, francesi a metà tra il loro vecchio mondo (l’Europa, da dove venivano) e il nuovo (l’America). Vivendo le praterie, Cather si affezionò alla gente. Quella campagna di erba ispida l’aveva afferrata con una passione che mai avrebbe ritenuto possibile e che mai sarebbe stata in grado di scrollarsi di dosso. Vinse il premio Pulitzer con One of ours, romanzo che porta all’estremo il tema dell’ambiguità tra il radicamento alla terra d’origine e l’irrequietezza che induce ad abbandonarla alla ricerca di sé. Così il protagonista, Claude Wheeler, si allontana dalle proprie origini contadine alla ricerca di una forma di elevazione intellettuale. La figura di Claude è disegnata con i tratti degli eroi mitici: Claude è puro e senza macchia come un moderno Parsifal, pronto a sacrificarsi combattendo per la patria. Si arruola per combattere la Prima Guerra Mondiale.
E così morirà, nobilmente innalzato a modello eroico. Dopo il Pulitzer divenne una delle autrici più vendute d’America. Nonostante la sua fama, subì giudizi pesantemente negativi da parte della critica che ridimensionarono la sua posizione nel panorama letterario. Così Cather diveniva sempre più solitaria. Bruciava le lettere che riceveva e impediva che quelle scritte da lei fossero pubblicate. Grazie alle attenzioni rivolte alle sue opere dalla critica femminista, fu nuovamente riscoperta negli anni Settanta. «La meta non è nulla, la strada è tutto», diceva.

La stessa fortuna non avrà Edna Ferber (1885-1968), brillante scrittrice nata in Michigan che toccò le vette del successo letterario ma non fu mai inclusa nel pantheon dei grandi autori americani. Vinse il Pulitzer nel 1925 con So big, romanzo che, anche nella traduzione italiana, mantiene il titolo originale, derivato dallo scambio di battute tra madre e figlio protagonisti («Quanto è grande il mio bambino?» […] Poi dicevano insieme, la bocca di lui un grinzoso petalo rosa, quella di lei tremante di tenerezza e di un certo divertimento, «So-o-o big!», grande così”). Lo scrisse quando aveva 39 anni e non si aspettava un tale successo. Era convinta che a nessuno interessasse la storia di Selina, contadina povera dai denti rovinati. Ma la parabola di Selina racchiude molti altri aspetti che vanno oltre la sua vicenda personale: Selina si muove nella Chicago dell’industrializzazione e del capitalismo, schiacciata dalla tragedia della fame e della povertà, affrontando l’esperienza della maternità in un contesto di profonda miseria.
La scelta del realismo mette in primo piano una figura femminile di straordinaria potenza, incastonata in un’alternanza narrativa di bozzetti di scene rapidissime e di momenti di indagine nella psiche dei personaggi. Il crudo realismo di Ferber è il risultato, con grande probabilità, delle tracce di autobiografismo presenti nella sua opera. Era nata nel 1885 a Kalamazoo, una cittadina industriale del Michigan. Suo padre era commerciante ebreo di origine ungherese; sua madre americana di seconda generazione e di origine tedesca. Dopo il fallimento professionale del padre si trasferirono nello Iowa. Poi ancora nel Wisconsin. La solitudine di Selina sarebbe stata la stessa provata da Ferber nella città della sua infanzia. Come Selina, Ferber incarna il sogno americano della self-made woman: a causa delle condizioni economiche precarie della sua famiglia, Ferber già a 17 anni lavorava come reporter di cronaca nera per un giornale locale.
A vent’anni era già una donna affermata e indipendente. Fu autrice di racconti ritenuti – con sua grande soddisfazione – scritti da un uomo sotto pseudonimo femminile. Dai suoi contemporanei era conosciuta come scrittrice di fiction seriali che apparivano sulle riviste femminili. Eppure Ferber aveva l’ambizione di scrivere il grande romanzo americano: visse l’età aurea della narrativa americana, da Sherwood Anderson a Fitzgerald, da Don Passos a Faulkner a Hemingway. E lei non voleva essere da meno, sognava un romanzo in cui l’America non era solo un’ambientazione ma il soggetto stesso. Il successo, poi, giunse anche attraverso l’industria di Hollywood: dai suoi romanzi furono tratti non meno di 25 film (Il gigante, con James Dean, è diventato un cult). Fu membro dell’ Algonquin Round Table, prestigioso gruppo letterario newyorkese di cui fecero parte anche Dorothy Parker e Robert Sherwood. Nonostante il suo successo, le enormi vendite dei suoi romanzi, Hollywood e il Pulitzer, per molti decenni fu ingiustamente esclusa dalle Storie della letteratura. Morì nel 1968, a 82 anni e non ebbe, nemmeno dopo la morte, le stesse attenzioni e rivalutazioni critiche di Wharton, Cather o Parker. Oggi So big è ritenuto un grande classico dei “ruggenti anni Venti”, capace di scene narrative magistrali, come il finale del romanzo vincitore del Pulitzer: aspro e privo di patetismo, il gesto finale di Dirk, il figlio di Selina, ormai adulto, diviene espressione dell’amarezza di un pentimento, della condanna di sé per l’abbandono dei propri valori artistici in virtù del perseguimento del denaro.

Un caso unico nella storia del premio Pulitzer è quello di una scrittrice che scrisse un unico, straordinario romanzo che divenne uno dei best seller più famosi al mondo. Margaret Mitchell (1900-1949) fu bella e ribelle proprio come la sua Rossella O’Hara, protagonista del celebre Via col vento.
Voce del Sud, nasce ad Atlanta, in Georgia, all’alba del secolo nuovo, nel 1900. Quando era bambina, il suo vestitino prese fuoco mentre giocava vicino al camino e fu talmente scossa da questo episodio che la madre cominciò a farle indossare i pantaloni. Così sembrava un maschio e cominciarono a chiamarla Jimmy. Ma lei ne era contenta: sembrando un maschio, poteva giocare a baseball anziché con le bambole.
La madre di Margaret, Maybelle Mitchell, fu una suffragetta tra le più attive, una di quella che ottenne il voto nel 1920. Era una donna estremamente severa, che voleva imporre alla figlia un’educazione letteraria, costringendola a leggere Dickens, Austen e Tolstoj. Per spirito di ribellione, Margaret preferiva essere punita e picchiata che assecondare gli ordini della madre e leggeva romanzi rosa e thriller. Sin da bambina Mitchell inventava drammi e opere teatrali in cui c’erano donne che si comportavano da uomini. Lei stessa creò per sé una nuova personalità, Peggy, che indossava abiti maschili e voleva essere scrittore, pugile, soldato. O assumere qualsiasi identità che le avesse dato accesso a forti emozioni.
Profondamente radicata nella cultura del Sud, Mitchell, tuttavia, si formò nella forte ideologia delle divisioni razziali tra bianchi e neri, fu parte di un mondo che, considerando tale divisioni la norma, non credeva nell’uguaglianza. Incisiva in questo senso fu l’esperienza traumatica delle rivolte razziali del 1906 ad Atlanta: Mitchell aveva solo sei anni. Tuttavia, questa prospettiva culturale cambiò radicalmente negli anni. Dopo l’enorme successo di Via col Vento, investirà i guadagni derivati dalle vendite in borse di studio per studenti afroamericani in medicina e odontoiatria dell’ “All-Black Morehouse College” di Atlanta. Lo farà in anonimato, come in anonimato finanzierà il primo ospedale per neri di Atlanta: «Verrà il tempo in cui Atlanta sarà la più grande città di neri del Sud. Quando arriverà quel momento, spero che avremo eccellenti medici neri per il personale di questo ospedale».
La vita di Margaret Mitchell fu segnata da profondi entusiasmi e altrettanto profondi dolori. Subì negli anni della giovinezza due incidenti da cavallo. Dopo un matrimonio fallito, fu costretta a trovare lavoro come reporter per l’Atlanta Journal Sunday Magazine. Intervistò persone famose (Rodolfo Valentino fu la sua intervista più prestigiosa), muovendosi da sola in mezzo agli uomini, frequentando zone pericolose della città. Nel 1925 (un anno dopo la separazione dal primo marito) si risposò con John Marsh, anche lui giornalista. E questa volta fu un matrimonio felice. Margaret continuò a scrivere per i giornali. Tuttavia un nuovo incidente alla gamba la costrinse alle stampelle: precipitata in un periodo di depressione acuta, lasciò il lavoro. Per confortarla il marito le portava montagne di libri da leggere; era una lettrice talmente vorace che lesse tutti i libri della biblioteca cittadina. Fu allora che il marito le consigliò di smettere di leggere e di scrivere lei il suo romanzo. E Margaret sapeva benissimo da dove cominciare: le venne in mente un episodio della sua infanzia, quando un giorno non voleva andare a scuola perché riteneva che apprendere l’aritmetica fosse stupido e inutile.
La madre, furiosa, la portò con sé per mostrarle le rovine delle case dei ricchi che erano state distrutte, anni prima, durante la guerra civile. Il mondo era esploso sotto i piedi di quei ricchi, disse la madre, e sarebbe arrivato il giorno in cui anche il mondo di Margaret sarebbe esploso sotto i suoi piedi. Era meglio che lei avesse qualcosa a cui aggrapparsi quando fosse successo. Qualcosa che fosse custodito dentro di sé. E quel qualcosa poteva essere solo la storia, il latino o l’aritmetica che tanto odiava. Quel giorno la madre le aveva insegnato che l’unica salvezza per una donna era la sua intelligenza. Così Margaret aveva trovato la sua storia: una storia ambientata durante la guerra civile. Cominciò a scrivere di Rossella O’Hara partendo dalla fine, dalla scena in cui, ritornando alla propria casa dopo l’ondata della guerra, la trova distrutta. Il suo lavoro di scrittura era per tutti, fuorché per il marito, un segreto, se non addirittura un tabù: era in guardia anche dal postino e dal lattaio e ogni volta che qualcuno entrava in casa gettava un asciugamano sopra la macchina da scrivere. Lavorò al romanzo dal 1926 al 1929, ma non si diede da fare per pubblicarlo. Fu convinta da un editore della McMillan, celebre casa editrice newyorkese, che aveva sentito parlare di lei. Il romanzo fu pubblicato il 30 giugno del 1936, nel pieno della Grande Depressione, e nei primi sei mesi vendette un milione di copie. Fu messo in vendita a tre dollari.
Dopo la pubblicazione del romanzo, la gente cominciò a tempestarla di telefonate per chiedere come continuasse la storia tra Rossella e Rhett, per sapere se Rhett sarebbe mai tornato da Rossella. La gente amò la loro storia d’amore ma non riuscì accettare che si separassero, finale tradotto poi per il cinema con la celeberrima scena di Rhett che abbandona Rossella addentrandosi nel paesaggio fumoso di un Paese devastato: «Frankly, my dear, I don’t give a damn» (“Francamente, mia cara, me ne infischio”). Quando Victor Fleming decise di trarre un film dal romanzo, Mitchell rifiutò di collaborare alla sceneggiatura perché se alla gente del suo Sud la resa cinematografica non fosse piaciuta, non l’avrebbero mai perdonata. Fu un successo mondiale e Mitchell fu improvvisamente una delle persone più famose al mondo. Tuttavia non amò il successo, piangeva quando squillava il telefono (e squillava ogni cinque minuti). Accettò solo di prendere parte alla prima del film, ad Atlanta. Conobbe gli attori: Clark Gable disse che era la donna più affascinante che avesse mai conosciuto.

Nel 1939 il Pulitzer andò al romanzo Il cucciolo di Marjorie Kinnan Rawlings (1896-1953). Fu interamente scritto sotto il portico della sua casa nella contea di Alachua, in Florida. Fu una vita selvaggia quella di Rawlings. Morto il padre, sua madre e suo fratello la seguirono nel Wisconsin quando si trasferì al college. Il suo futuro marito partì per la Prima Guerra Mondiale e nel frattempo lei si laureò. Quando lui tornò dalla guerra si sposarono e si trasferirono a New York, la città delle possibilità. La coppia tornava spesso in Florida durante l’anno, specialmente in estate. Finché Rawlings, talmente innamorata di quella terra, volle vendere la casa a New York per tornare nei suoi luoghi d’origine. Suo cognato trovò per lei e per il marito un boschetto con 1600 agrumi. Così sarebbe stata la loro vita insieme: a Cross Creek, (fu anche girato un film sulla sua vita, dal titolo Cross Creek, nel 1983), lei e il marito, entrambi scrittori, sarebbero vissuti del ricavato dalla vendita degli agrumi per potersi dedicare interamente alla scrittura. Rawlings si interessò alle vite delle comunità nelle foreste della Florida centro-settentrionale, comprendendo il significato di vivere a stretto contatto con l’ambiente.
Era una donna innamorata della vita selvaggia, si sentiva viva in mezzo ai maiali e agli orsi. In una fitta corrispondenza con Maxwell Perkins, Rawlings fu esortata a trasformare le storie di quelle persone della Florida di cui parlava nelle sue lettere – di chi si procacciava da mangiare nei boschi, con pesci e uccelli, di chi viveva una vita scandita dalle fasi lunari – in un romanzo. Scrisse Il cucciolo in poco tempo. Era estremamente veloce. Le parole comparivano sulla carta come un unico flusso naturale. In questo romanzo esplode tutta l’autentica energia della natura. Rawlings indaga quanto c’è di potente in un rapporto tra uomo e animale, quanto potremmo davvero non aver bisogno di alcun comfort e vivere solo immersi nella bellezza di un bosco per essere in pace. In ambito critico, molti studiosi di Rawlings si sono chiesti se Il cucciolo fosse un romanzo di formazione. Il protagonista, Jody Baxter, affronta un percorso di crescita nel momento in cui tenta di fare di un cucciolo di cervo un animale domestico. Ma quando l’animale mangia le provviste di grano che la famiglia di Jody aveva messo da parte per l’inverno, il padre impone al ragazzo di sparare al cervo. Jody e il cervo fuggono assieme: in una delle scene più drammatiche, il ragazzo abbandona l’animale nel bosco, cercando di allontanarlo da sé bruscamente, con parole aspre e offensive, solo per farsi forza, intimando all’animale di non tornare mai più.

Con In This Our Life di Ellen Glasgow (1873-1945), si ritorna alle vette aristocratiche che avevamo incontrato con Edith Wharton. Glasgow nasce e muore a Richmond, in Virginia in una famiglia agiata. Costretta dalla salute precaria a una formazione da autodidatta, fu ostacolata dalla famiglia nell’ambizione letteraria. È stata spesso relegata dalla critica a scrittrice regionalista, commento che mai sarebbe stato accettabile nei confronti di altri scrittori del Sud come Faulkner, Welty, Wolfe. I suoi romanzi raccontano un Sud sicuramente più vicino a una tradizione nostalgica ottocentesca che, tuttavia, si libera dell’ingombro del passato per avviarsi alla modernità. Glasgow non aveva bisogno di edulcorare il racconto del Sud attraverso illusioni che la proteggessero dalla realtà delle cose: l’ordine aristocratico volgeva al tramonto. Così progettò una serie di romanzi che fossero degli schizzi sulla vita in Virginia: The Descendant, Barren Ground e The Sheltered Life. In questa nostra vita è il suo ultimo romanzo. Una discesa quasi infernale nell’interiorità del protagonista che, osservando la realtà che lo circonda, si sente pronto a liberarsi delle illusioni di una società aristocratica che è quanto più possibile lontana dalla perfezione. Con un romanzo che indaga le crepe della società e della famiglia, Glasgow denuncia la decadenza di istituzioni incastonate nel sud del sud degli Stati Uniti. «Un tramonto fumoso oscurava la via e i lampioni vicini alla casa vuota non erano ancora accesi. Sotto un cielo corrucciato il vecchio edificio appariva deserto ma dall’aria vissuta». Nell’incipit del romanzo il vecchio edificio dall’aria vissuta sembra farsi correlativo oggettivo di qualcosa di molto più grande: un Sud ancorato al passato, vecchio, dall’aria vissuta. Che urla la sua disperazione e la sua necessità di cambiamento.

Adele Errico