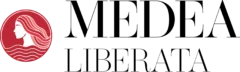Save The Children ha pubblicato, lo scorso 6 maggio, la 10ma edizione del rapporto “Le Equilibriste – La maternità in Italia 2025” , mostrando come le madri siano sempre più sole e penalizzate, anche a rischio povertà.
Cosa significa essere madre? Sicuramente la risposta a questa domanda varia di donna in donna, di madre in madre. Ma un’affermazione rimane scolpita nella pietra e le accomuna tutte: l’Italia non è affatto un Paese per madri. Costrette a rinunciare al lavoro, alla carriera, costrette a gestire il tempo, a rinunciare alla vicinanza totale a un figlio o una figlia. Costrette sempre a scegliere, da sole e penalizzate. A stare in bilico fra quello che si può e si deve fare. Per se stesse e per i figli.
Il rapporto Le Equilibriste – La maternità in Italia 2025, pubblicato da Save the Children in occasione della Festa della Mamma, offre un’analisi dettagliata delle sfide che le donne italiane affrontano nel conciliare maternità, lavoro e vita privata. Inoltre, il report include anche l’Indice delle Madri, elaborato dall’ISTAT proprio per Save the Children, ovvero una classifica delle regioni italiane dove per le mamme è più facile o difficile vivere.
Natalità in calo e maternità posticipata
Il 2024 ha registrato un nuovo minimo storico di nascite, con soli 370.000 nuovi nati, segnando una flessione del 2,6% rispetto all’anno precedente. Questo declino si riflette nel tasso di natalità, sceso a 6,3 nati ogni 1.000 abitanti, in diminuzione rispetto al 6,4 dell’anno precedente. L’età media delle madri al parto ha raggiunto i 32,6 anni, mentre il tasso di fecondità totale è sceso a 1,18 figli per donna, inferiore anche al minimo storico dell’1,19 registrato nel 1995. Un fattore rilevante è legato al cambiamento strutturale della popolazione femminile in età feconda, convenzionalmente compresa tra i 15 e i 49 anni, una fascia di età in cui il numero di donne è in costante diminuzione. Questi numeri riflettono cambiamenti profondi nella società italiana e nelle scelte di vita delle donne e delle coppie. Il fenomeno della denatalità non risparmia nessuna area del Paese, ma si manifesta con intensità diverse. Il Sud e le Isole hanno registrato i cali più significativi di nuove nascite, rispettivamente del 4,2% e del 4,9%.
Le “madri single”: “equilibriste tra le equilibriste”
I dati ISTAT rivelano un aumento significativo dei nuclei monoparentali (definiti “single”). Nel 2024, si contano 716 mila madri tra i 25 e i 54 anni con almeno un figlio minorenne, in aumento rispetto all’anno precedente, quando erano 702 mila. Tali cambiamenti riflettono trasformazioni sociali più ampie, tra cui l’aumento delle separazioni, dei divorzi e delle persone che vivono sole. oggi la maggior parte delle famiglie monogenitoriali comprende adulti che hanno attraversato un percorso di separazione o divorzio. Il 48% dei genitori nelle famiglie monogenitoriali sono separati o divorziati, mentre nubili e celibi rappresentano il 18,3% e il restante 33,7% è composto da vedove e vedovi. Nel 37,6% di queste famiglie vivono figli minori (9,6% fino a 5 anni; 17,4% 6-13 anni; 10,6% 14-17 anni). Ad essere prevalenti sono le famiglie monogenitoriali con un solo figlio, che costituiscono il 68,2% del totale.
Le madri in famiglie monogenitoriali rappresentano una categoria particolarmente vulnerabile. Nel 2024 tra i nuclei monoparentali il rischio di povertà o esclusione sociale ha raggiunto il 32,1%, contro il 21,2% delle coppie con figli e il 25,6 dei nuclei con almeno un figlio minorenne. Solo poco più della metà delle madri single tra i 25 e i 34 anni è occupata, con un tasso di occupazione che supera l’83% nel Nord, ma scende al 45,2% nel Mezzogiorno. Queste donne affrontano ostacoli aggiuntivi in termini di supporto sociale e stabilità economica. Tra le famiglie monoparentali con figli sotto i 16 anni, il rischio di povertà o esclusione sociale era pari al 39,1% (contro il 27,2% delle coppie), ma saliva al 41,3% nel caso di madri sole, percentuale che scendeva al 27,6% per i padri soli. Questo evidenzia una situazione di particolare fragilità economica per le donne sole con figli minori, molto più accentuata rispetto agli uomini nella stessa condizione. Questi dati non fanno che confermare e rendere quantitativamente evidente il forte svantaggio e le discriminazioni di genere che le donne, e in particolare le madri sole, devono affrontare nel mercato del lavoro italiano e nel sistema di welfare.
Disparità lavorativa di genere
I dati sul tasso di occupazione per la fascia di età 25-54 anni nel 2024 mostrano un evidente divario di genere legato alla presenza di figli. Gli uomini presentano livelli occupazionali molto elevati anche quando hanno i figli, ma la partecipazione è strettamente legata alla condizione familiare, in maniera opposta rispetto a quanto accade per le donne. Il 77,8% degli uomini senza figli lavora, ma questa percentuale sale al 91,5% tra i padri e raggiunge il 91,9% tra quelli con almeno un figlio minore. Il valore resta sopra il 91% anche per i padri con due o più figli sotto i 18 anni. Il dato medio complessivo per gli uomini è dell’84,1%. Per le donne la situazione è radicalmente diversa: l’occupazione è pari al 68,9% tra quelle senza figli, ma scende al 62,3% tra le madri. Anche guardando solo alle donne con figli minori, il tasso sale leggermente al 65,6% se si ha un solo figlio, ma scende al 60,1% tra chi ha due o più figli minori. Il dato complessivo per le donne è del 64,9%, quasi venti punti percentuali in meno rispetto agli uomini.
Disparità territoriali e sociali della maternità in Italia
Al Nord, il tasso di occupazione maschile è dell’87% per gli uomini senza figli e 96,3% per quelli con almeno un figlio minore. Mentre per le donne si attesta all’80,2% per le donne senza figli, e al 74,2% per quelle con almeno un figlio minore. Anche nelle regioni del Centro emerge uno svantaggio femminile nei tassi di occupazione: per le donne senza figli è del 74,3% e quelle con figli minori è del 69,2%. Nel Mezzogiorno, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è molto più bassa e presenta comunque una differenza tra le donne senza figli (49,4%) e quelle con almeno un figlio minore (44,3%), in linea con quelle del Centro e del Nord. In tutte le ripartizioni, quindi, gli uomini con figli lavorano di più degli uomini senza figli, mentre per le donne vale l’opposto: avere figli è associato a una minore partecipazione al lavoro.
La disoccupazione in Italia e al Sud
I dati 2024 mostrano che la disoccupazione è più alta tra le donne rispetto agli uomini. In media, nel gruppo 25-54enni, il tasso di disoccupazione è del 7,5% per le donne e del 5,6% per gli uomini. La disoccupazione è leggermente contenuta per chi ha figli, con un tasso di disoccupazione pari al 4,8% tra quanti hanno almeno un figlio minore e all’8,1% tra chi non ha figli. Le donne sono svantaggiate in tutte le fasce d’età, con un picco tra le giovani donne (25-34 anni) con figli minori, che raggiungono un tasso di disoccupazione del 9,0%, contro il 4,9% dei coetanei uomini nelle stesse condizioni. Il divario di genere è ancora più netto, pari quasi al doppio, tra le giovani con due o più figli minori: 12,5% per le donne 25-34enni contro il 6,5% per gli uomini della stessa fascia d’età con due o più figli minori. Nel Mezzogiorno, il quadro è critico per tutte le categorie, ma in particolare per le donne 25-54enni senza figli (17,9%) e con almeno un figlio minore (11,6%), evidenziando una doppia penalizzazione territoriale e di genere. Anche gli uomini, pur mostrando livelli più bassi, registrano una disoccupazione elevata: il 15,0% per gli uomini 25-54enni senza figli e il 6,6% degli uomini 25-54enni con almeno un figlio minore.
Le raccomandazioni per migliorare la condizione delle madri in Italia:
- Riduzione dei costi dei servizi per l’infanzia: una diminuzione del 30% dei costi potrebbe ridurre significativamente il divario occupazionale tra madri e padri.
- Ampliamento dell’offerta di asili nido: per garantire un sostegno concreto alle famiglie e favorire la partecipazione delle madri al mercato del lavoro.
- Politiche di conciliazione vita-lavoro: implementazione di misure che facilitino l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali.
L’Indice delle Madri: le regioni più e meno “mother friendly”
Il rapporto presenta un Indice delle Madri per regione, basato su 14 indicatori che includono demografia, lavoro, rappresentanza politica, salute, servizi, soddisfazione soggettiva e violenza. La Provincia autonoma di Bolzano, l’Emilia-Romagna e la Toscana si posizionano ai primi posti, mentre la Basilicata si conferma all’ultimo posto, preceduta da Campania, Puglia e Calabria.
Anche quest’anno, i dati restituiscono un quadro marcato da forti divari: nella partecipazione al mercato del lavoro, nelle differenze salariali, nella difficoltà persistente per molte donne di far coesistere progetti di maternità e percorsi professionali e di realizzazione personale. Accanto a questi squilibri, si evidenziano anche le diseguaglianze tra le stesse equilibriste: in particolare, le madri single affrontano una condizione di vulnerabilità acuita, in cui la solitudine nella cura e nelle responsabilità economiche si traduce in un’esposizione ancora maggiore al rischio di esclusione, precarietà e rinuncia. È un gruppo sociale che non ha fino ad oggi ricevuto la giusta attenzione in termini di politiche, eppure è un gruppo crescente; come accennato anche in introduzione, si stima che le madri sole nei prossimi vent’anni (precisamente nel 2043) saranno 2,3 milioni, con bisogni di supporto specifici.
Il rapporto completo è disponibile qui: Le Equilibriste – La maternità in Italia 2025.